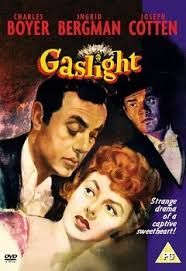Psicologo di Base non solo un sogno! Intervista su La Repubblica – Affari e Finanza al Presidente Palma.
Il sogno degli psicologi affiancare i medici di base
La proposta dell’Ordine consentirebbe, secondo il suo presidente, di ripagare i costi pubblici della operazione con i risparmi conseguibili dalla riduzione delle spese: “Molte malattie sono psicosomatiche”
VALENTINA CONTE
Roma
Mettere insieme, nello stesso ambulatorio, un medico di base e uno psicologo. Uno di fianco all’altro. Una scelta non solo possibile, ma anche profittevole. Per il paziente, per i medici e per la sanità pubblica. Perché non sempre la malattia si sconfigge con le medicine o la chirurgia. Anzi, sempre più spesso la domanda di salute è una domanda di benessere. È la voglia di superare il disagio. È il desiderio di rinascere, di risolvere i nodi che bloccano la psiche e, dunque, anche il corpo. Medico e psicologo insieme è anche una scelta già sperimentata. Da più di dieci anni il professor Luigi Solano, docente di psicosomatica alla Sapienza di Roma, segue in alcuni ambulatori della capitale l’inedito affiancamento professionale, grazie al supporto degli specializzandi in Psicologia della salute dell’ateneo romano. I risultati sono talmente positivi, e confortati da prestigiosa letteratura internazionale, da spingere il presidente dell’Ordine nazionale degli psicologi, Giuseppe Palma, a cercare interlocutori istituzionali disposti a finanziare la sperimentazione anche altrove. «In un anno l’apporto di ogni psicologo ha consentito di risparmiare in media 75 mila euro sulla spesa farmaceutica, moltiplicato per due, perché erano due gli studi serviti da ciascuno di loro», spiega Palma. «Un risparmio che certo supera di gran lunga il costo dello stipendio di uno psicologo». Ma perché si arriverebbe a risparmiare così tanto? «I dati della ricerca ci dicono che il 50% dei pazienti che va dai medici di base porta domande di salute diverse da quelle tradizionali, ma viene trattato come si fa in presenza delle classiche patologie e quindi con farmaci e prescrizioni di analisi cliniche. Risposte inappropriate nella metà dei casi. Perché molti malesseri, prima di divenire patologici, possono essere curati in modo diverso», spiega ancora Palma. «La gratitudine dei pazienti è l’eredità più preziosa che conservo di quell’esperienza», racconta Alessandra Marchina, 36 anni, psicologa della salute che, assieme ad altri sette colleghi, ha partecipato alla sperimentazione. «In tre anni ho incontrato 600 persone. Un solo paziente ha chiesto di essere visitato esclusivamente dal suo medico. Gli altri, prima incuriositi poi sempre più liberi, hanno non solo accolto la mia presenza, ma ne hanno tratto giovamento. In almeno cento casi abbiamo individuato un disagio psico-sociale distribuito in diverse aree: familiare, di coppia, lutto, lavoro, maternità, immigrazione. Dal divorzio alla fecondazione assistita, dalla simbiosi genitori-figli alla solitudine dell’extra-comunitario, dal mobbing all’aborto. Si era creato, in quello studio e per la prima volta, uno spazio di ascolto e di aiuto nuovo». Sperimentare l’affiancamento medico-psicologo ha un costo. E in questo momento i bilanci delle sanità regionali sono quasi tutti in rosso. «Ne siamo consapevoli, tuttavia i risparmi sarebbero superiori alla spesa, la ricerca del professor Solano è lì a dimostrarlo, e il beneficio per la collettività enorme», risponde Palma che conferma, intanto, l’interessamento dell’assessore alla sanità pugliese Tommaso Fiore. Oltre ai risparmi per la collettività, la sperimentazione incorpora un obiettivo ancora più ambizioso: la definizione di una proposta di legge ad hoc, per istituzionalizzare questa presenza negli studi medici. «Ma prima sperimentiamo. Abbiamo bisogno di dati ancora più robusti e dettagliati sul territorio italiano», precisa Palma. In parlamento un ddl in materia esiste, ormai dimenticato. All’Ordine, però, non piace perché affida il ruolo di affiancamento a figure diverse dallo psicologo. In Italia gli psicologi sono tantissimi: 80 mila, un terzo di quelli europei, un quarto del mondo. Ed è un settore in rosa, visto che l’80% degli iscritti è donna e questa percentuale sale al 95% tra i professionisti under- 30. I più critici intravvedono nella richiesta di sperimentazione un tentativo lobbistico di risolvere un’emergenza occupazionale. «Ogni anno cresciamo di 6 mila iscritti. E degli 80 mila psicologi italiani la metà è disoccupata», conferma il presidente Palma. «Più volte abbiamo chiesto il numero programmato nelle università. Tuttavia il progetto che proponiamo ha una sua validità. Noi siamo convinti che valga la pena sperimentare ». «Un ingegnere di 40 anni è venuto da me presentando sintomi di astenia e capogiro. Convinto di avere un tumore, scopriamo che non aveva bisogno di alcuna risonanza magnetica. Ma di recuperare i suoi spazi e il suo sprint, negati dall’ansia di dover accudire la mamma anziana e vedova. Così è stato. Dopo solo tre sedute con la psicologa, ha recuperato tutta la sua salute», racconta Enzo Pirrotta, medico di base romano, coinvolto nel progetto pilota. «Sempre più oggi i fattori determinanti per la salute sono bio-psico- sociali. E se tutto ricade sul medico generale si rischia un cortocircuito. Su 1.300 pazienti visitati durante la sperimentazione, 857 non erano malati, ma stavano male perché avevano un disagio psicologico. E nella metà dei casi questo disagio nasceva all’interno della famiglia. Solo il 5% degli italiani ha avuto nella sua vita un contatto con lo psicologo. È una discrepanza, uno stigma, una barriera culturale da superare. Tanto più che l’ultimo contratto nazionale consente ai medici di base di assumere direttamente infermieri, operatori della riabilitazione o socio-sanitari per l’assistenza a domicilio, ostetrici. Perché non gli psicologi, visto che non si parla più di medicina generale, ma di cura primaria?».
http://www.psy.it/documenti/LaRepubblicaAffariFinanza13062011.pdf
Medico: prova ad ascoltare!
Dall’ultimo report di «PatientView»: interpellate 2.500 associazioni di pazienti in 35 Paesi – Manca l’alleanza
I camici bianchi di mezzo mondo sono autorizzati a sprofondare nello sconforto: milioni e milioni di pazienti sono convinti che i medici “ostacolino” il loro accesso alle cure, costringendoli a “combattere con il sistema” per ottenere le risposte di cui necessitano. E a formulare il giudizio meno lusinghiero sui propri sanitari sono canadesi, tedeschi, italiani, neo zelandesi e britannici, convinti nel 60% dei casi che i medici debbano quanto meno raffinare le proprie capacità di dialogo con i propri assistiti. A disegnare l’identikit mondiale dello scontento nella relazione medico-paziente è un rapporto di 400 pagine appena pubblicato da «PatientView », organizzazione di ricerca indipendente britannica che lavora a stretto contatto con le organizzazioni dei pazienti e i gruppi attivi nel settore sanitario e sociale a livello mondiale.
Il Report in questione – intitolato «What do patient think of doctors?» – è stato realizzato analizzando le opinioni di circa 2.500 associazioni nazionali e internazionali di pazienti di oltre 35 Paesi tra cui figurano oltre 55 diverse aree specialistiche che vanno dalle malattie rare alle patologie croniche. Quesito centrale dell’indagine – realizzata nel novembre 2010 – che ne pensano i pazienti dei medici. O meglio: “come può essere migliorata la relazione medico paziente?”. Sotto la lente in particolare Australia, Canada; Europa orientale, Francia, Germania, Italia, Olanda, Nuova Zelanda, Spagna, Svezia Regno Unito e Stati Uniti.
Tra le specialità sono rappresentate invece oncologia, patologie gastro-intestinali, cardiocircolatorio, salute mentale, sclerosi multipla, neurologia, Parkinson, malattie rare, respiratorie e reumatologiche. Frutto di una sorta di plebiscito che non conosce frontiere, il primo dato a esplodere con schiacciante evidenza è quello relativo alla mancanza d’ascolto da parte dei professionisti della salute: a eccezione dei pazienti dell’Europa orientale e di quelli affetti da Hiv-Aids, solo una minoranza delle associazioni consultate ritiene che i rapporti medico paziente siano ancora caratterizzati da un atteggiamento tradizionale e paternalistico. Allo stesso modo, però, solo una minoranza ritiene che i medici siano orientati a trattare i pazienti in modo paritario.
L’unica eccezione si riferisce agli specialisti come neurologi o geriatri impegnati nella gestione delle persone affette dal morbo di Parkinson: il 50% dei pazienti si sente considerato come partner dal proprio medico. Ma cosa si aspettano davvero i pazienti malati quando si rivolgono a un camice bianco? La risposta – che soprattutto di questi tempi deve far riflettere – è che il 72% desidera ricevere trattamenti che consentano al paziente di “condurre una vita normale o quasi” anche “mettendo a rischio l’aspettativa di vita dell’assistito”, come ha cura di specificare il 39% dei rispondenti. E quali interventi sarebbero necessari per migliorare il rapporto medico paziente? Tre le risposte più gettonate: migliorare la qualità di vita del paziente grazie alle cure praticate (19%), migliorare il livello di comunicazione (17%), migliorare la possibilità di accesso agli specialisti. Sul come si fa a migliorare la qualità di vita del paziente, le risposte variano ovviamente da Paese a Paese e in rapporto al tipo di specialità di riferimento, ma ben il 53% dei rispondenti si è trovato d’accordo nel sostenere che i professionisti del settore dovrebbero occuparsi dei pazienti senza costringerli a lottare con il sistema per diagnosi e terapia, mentre il 49% pensa che il medico dovrebbe fornire i trattamenti ritenuti più efficaci indipendentemente dal costo.
Il 45%, infine, vorrebbe che il medico mantenesse un rapporto continuo con il paziente sostenendolo anche nella gestione personale della malattia o nell’accesso a team specialistici multidisciplinari. Ma cosa devono fare i professionisti in camice per migliorare la propria capacità di comunicazione con gli assistiti? “Guardare al paziente come a una persona e non come a un problema sanitario”, risponde oltre metà del campione. Ma anche discutere a fondo tutte le opzioni terapeutiche con il paziente prima di avviare una cura (48%), fornire più informazioni sulla situazione sanitaria del paziente (46%), fornire più informazioni che aiutino il paziente a gestire la propria patologia (44%). A confermare che l’immagine di una alleanza terapeutica medico-paziente merita d’essere rinverdita sono anche le richieste indirizzate agli specialisti. Oltre il 50% dei pazienti chiede nell’ordine: di disporre di un tempo sufficiente per il consulto (62%); di poter contare su informazioni pubbliche chiare e tempestive in merito ai migliori specialisti disponibili per una determinata patologia (59%); di poter scegliere liberamente lo specialista a cui rivolgersi (42%); di poter contare sulla puntualità dei professionisti, evitando lunghe soste in sala d’attesa (50 per cento). Una terna di risposte gettonatissime anche per la scelta degli stakeholder potenzialmente capaci di migliorare il rapporto medico-paziente: al primo posto gli infermieri (65% di citazioni), seguiti dai Governi nazionali (62%) e locali (51 per cento). Sotto la lente, infine, anche il ruolo giocato dalle aziende farmaceutiche e dalle altre aziende del settore.
I più convinti nel sostenere che i produttori possono giocare un ruolo importante nel migliorare i rapporti medico-paziente sono gli spagnoli (58% di citazioni per le aziende farmaceutiche; 60% per le aziende di biomedicali); tassi decisamente inferiori in Italia (51% e 47 per cento). Il questionario ha comunque consentito di individuare una lista di circa 70 aziende che compiono azioni ritenute positive per la relazione indagata (perché “fanno ricerca”; “monitorizzano la performance dei prodotti”; “forniscono ai medici suggerimenti nell’ottica del paziente”; “aiutano i pazienti a rapportarsi con i sistemi sanitari” e così via). Italia: voglia di “voti” agli specialisti. Nel panorama descritto da «PatientView » la situazione italiana non risulta decisamente tra le più brillanti. Circa un quarto delle associazioni di pazienti interpellate (110 in tutto, a carattere internazionale, nazionale e locale, in rappresentanza di circa 1,2 milioni di pazienti) è convinto che il rapporto tra i pazienti e i professionisti del settore sanitario resti tradizionale e patriarcale. Ben il 77% dei rispondenti è convinto che l’accesso ai medici di famiglia e ai relativi servizi potrebbe essere migliorato, mentre ben l’84% reclama informazioni pubbliche comprensibili e facilmente disponibili in merito agli specialisti dotati di maggior perizia nell’attività professionale: il 44%, infine, vorrebbe avere maggior voce in capitolo nella scelta dello specialista a cui rivolgersi.
Analogamente a quanto già registrato nei risultati generali dello studio, i pazienti italiani ritengono che il rapporto medico-paziente migliorerebbe significativamente se il medico discutesse in modo esteso le opzioni terapeutiche con il paziente (72%), fornisse più informazioni sulla diagnosi (52%) e sul rapporto rischio-beneficio dei trattamenti (41 per cento). Ma la vera panacea sarebbe un medico tanto “schierato” da fornire informazioni sui diritti dei pazienti (57%) e da affiancarli in tutte le situazioni della vita quotidiana condizionate dalla malattia (53%), come ad esempio i problemi lavorativi. Convinti infine che anche il loro tempo sia denaro, oltre metà del campione di pazienti italiani interpellati gradirebbe maggiore attenzione da parte degli specialisti al fattore puntualità (52%) e preferirebbe veder rispettate le proprie esigenze (22%) piuttosto che quelle del camice con cui hanno appuntamento. Idee chiarissime, infine, sugli aspetti che possono fare la differenza in ambito professionale: il 37% dei gruppi pazienti italiani sostengono che i professionisti del settore sono più “affidabili” quando dedicano alla formazione continua un impegno superiore a quello previsto dalla legge, mentre il 20% segnala come “responsabili” i medici che accettano di verificare i possibili reclami da parte degli assistiti, senza porre ostacoli difensivisti in materia.
Viste le tante mancanze a che santo votarsi? Per l’84% delle associazioni di pazienti italiani il compito di migliorare il rapporto medico-paziente spetta ai governi locali, ma l’80% attribuisce un ruolo decisivo anche agli infermieri, il 65% cita in tal senso il governo nazionale, il 45% dice che anche i farmacisti possono fare la loro parte. Il 51% dei gruppi cita infine le aziende farmaceutiche e il 47% i produttori di elettromedicali. Tanti deus ex machina, insomma, per un unico problema: per curare davvero il medico deve – prima – imparare ad ascoltare.
Fonte: http://www.aipsimed.org/
Tratto da opsonline
Lo psicologo: che scocciatura!
Trascrivo la segnalazione di un articolo comparso sul sito internet affaritaliani.it in cui viene sponsorizzata la figura del coach e in cui mi sembra che lo psicologo non ne esca tanto bene.
LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE
http://www.affaritaliani.it/coffeebreak/coach191110.html
COMMENTO DELLA REDAZIONE “OSSERVATORIO PSICOLOGIA NEI MEDIA” A CURA DELLA DOTT. SSA ILARIA FABBRI
L’International Coach Federation (ICF), che rappresenta attualmente una delle organizzazioni più autorevoli nel suo campo, definisce il coaching professionale come un rapporto di partnership che si stabilisce tra coach e cliente con lo scopo di aiutare questo ultimo ad ottenere risultati ottimali in ambito sia lavorativo che personale (1); e prosegue riconoscendone il nucleo fondamentale nei termini di una relazione fondata sul rispetto e sull’apprezzamento reciproco come persone. Secondo l’ICF, il coaching rappresenta un intervento che accelera la crescita dell’individuo, permette un accrescimento nelle capacità di pensiero e nella presa di decisioni, un miglioramento nell’efficienza interpersonale, nelle aree della produttività e della soddisfazione personale, oltre a consentire il raggiungimento di importanti obiettivi personali (1). Il coaching è un intervento che si focalizza esclusivamente sul presente e sul futuro del cliente, in cui viene valutata la situazione attuale di partenza (“dove si trova il cliente oggi”) e quali sono le mosse da fare per raggiungere gli obiettivi preposti (“la meta in cui vorrebbe trovarsi domani”) (1). I suoi destinatari sono persone in grado di gestire efficacemente la propria vita, persone creative e ricche di risorse, che non stanno cioè cercando una guarigione emotiva o sollievi da un dolore psicologico, ma, al contrario, che vorrebbero raggiungere un livello più elevato di performance, di apprendimento o di soddisfazione (1). Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per fornire una maggiore comprensione rispetto agli approcci utilizzati, l’ICF ha definito le undici competenze chiave del coaching:
1.Conoscenza delle linee guida etiche e delle norme professionali e capacità di applicarle in modo adeguato in tutte le situazioni di coaching
2.Definizione del contratto/accordo di coaching
3.Capacità di creare sicurezza, fiducia e confidenza con il cliente
4.Presenza nel coaching, cioè la creazione di relazioni spontanee con il cliente, impiegando uno stile aperto, flessibile e confidenziale
5.Ascolto attivo, cioè capacità di concentrarsi completamente su ciò che il cliente sta dicendo e su ciò che non sta dicendo, di comprenderne il significato e di sostenere l’auto-espressione/spontaneità del cliente
6.Domande potenti, che consistono nella capacità di porre le giuste domande per il massimo beneficio nel rapporto tra il coach e il cliente
7.Comunicazione diretta attraverso la capacità di comunicare in modo efficace nel corso delle sessioni di coaching e di utilizzare un linguaggio che abbia il maggior impatto positivo possibile sul cliente
8.Creazione di consapevolezza nel clienti
9.Progettazione di azioni efficacemente orientate ai risultati prefissati
10.Determinazione degli obiettivi
11.Gestione dei progressi e delle responsabilità del cliente
Nel contesto organizzativo odierno il coaching, come attività di formazione e di consulenza professionale, viene prestato a vari livelli, anche se per anni il suo contesto naturale è stato quello sportivo. In questo ambito il termine “coach” ha designato da sempre la figura professionale che indirizza le sue competenze verso lo sviluppo delle capacità generali dell’atleta e verso l’ottimizzazione di queste stesse capacità precedentemente potenziate durante lo svolgimento della gara o dell’evento sportivo (2). Nel tempo il termine “coaching” si è rivestito di una miriade di appellativi, da executive coaching, personal coaching, job coaching, etc., ma indipendentemente dalle sfumature di significato che di volta in volta assume, l’idea che muove l’intero processo di coaching è da sempre quella dell’empowerment (3). Questo costrutto si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni ottanta all’interno della Psicologia di Comunità e indica un concetto positivo, multidimensionale, che si colloca nell’interazione attiva tra individuo e ambiente sociale di appartenenza (4). Letteralmente il termine empowerment, che deriva dal verbo inglese to empower, significa “favorire l’acquisizione di potere, rendere in grado di” e quindi si riferisce al processo tramite il quale le persone possono accrescere la possibilità di controllare la propria vita, possono acquisire o riscoprire la padronanza di capacità che rinforzano il senso di sé, che stimolano una consapevolezza critica della realtà e inducono all’azione e alla mobilizzazione delle proprie risorse (3). Il processo di empowerment è sostanziato in realtà da alcuni fattori psicologici, quali la self-efficacy, il locus of control interno, l’hopefullness, l’autostima, il vissuto di azione e di protagonismo, l’intelligenza emotiva (4). Dunque, verrebbe da chiedersi: se c’è così tanto di psicologico nel processo di empowerment e se è vero che questo costrutto, insieme a quello di relazione, intesa come esperienza in comune e condizione che comporta sempre reciprocità (5), costituiscono le fondamenta basilari del coaching (1), allora il coaching non dovrebbe essere uno tra gli ambiti di competenza propri dello psicologo?
Secondo l’ICF, il coaching non è una psicoterapia e la guarigione emotiva non è interesse del coaching (1). Questa è cosa certa. Il coaching è un intervento non clinico, volto a scoprire o a ri-attivare nuove strategie di azione più funzionali al raggiungimento di certi obiettivi, ma proprio per questa ragione è davvero molto simile ad alcune tipologie di intervento psicologico, per esempio di counseling, di psicologia del lavoro o di promozione della salute. Infatti è bene ricordare che lo psicologo non si occupa soltanto di clinica, ma sempre e comunque lavora secondo i principi del suo Codice Deontologico e quindi, secondo quanto si legge nel terzo articolo, “…in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace” (6). Allora dove sta il fraintendimento? Per quale ragione molte aziende richiedono un intervento di job coaching e molto più raramente si rivolgono ad uno psicologo del lavoro? E perché il privato cittadino che non è soddisfatto di qualche aspetto della sua vita chiede aiuto ad un life coach, ma difficilmente pensa che qualche colloquio con lo psicologo potrebbe sortire lo stesso effetto? La società in cui viviamo è davvero ancora così schiava del luogo comune secondo il quale chi va dallo psicologo è “fuori di testa”? Oppure è l’aspettativa di un percorso lungo, impegnativo ed economicamente dispendioso ad orientare le persone, privati cittadini o aziende, verso tipologie di intervento diverse da quello psicologico? O semplicemente l’insieme di tutti questi aspetti e magari di altro ancora determina il recente successo del coaching?
Se prendiamo in esame i rispettivi percorsi di formazione professionale, emerge che si diventa coach grazie a corsi privati offerti da svariate scuole certificate presenti sul territorio. La formazione professionale del coach si svolge in genere durante alcune giornate d’aula, sicuramente intense e ricche di esercitazioni pratiche, ma che si esauriscono pur sempre nel giro di qualche mese e senza che siano stati richiesti requisiti specifici per accedervi. Lo psicologo, al contrario, si forma grazie ad un percorso costituito da cinque anni di studi universitari, vari tirocini professionalizzanti, il superamento di un esame di Stato e l’iscrizione ad un Ordine regionale. A tutto ciò spesso si aggiungono corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, percorsi psicologici personali od altro, dal momento che, secondo quanto si legge nel quinto articolo del Codice Deontologico, “..lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera..” (6). Al di là delle differenze nel percorso di formazione, esistono tuttavia alcune analogie nelle prestazioni professionali. Entrambe queste figure utilizzano la relazione con il cliente come strumento elettivo del loro lavoro, fanno riferimento a precise norme professionali e teoriche (anche deontologiche, nel caso dello psicologo), definiscono generalmente un contratto-accordo con il cliente (grazie ad un’accurata analisi della domanda, almeno nel caso dello psicologo), cercano di creare relazioni spontanee con il cliente (ma soprattutto basate sulla sincerità, almeno nel caso dello psicologo) utilizzando modalità di comunicazione dirette e l’ascolto attivo. Il lavoro di entrambe queste figure professionali è volto a creare un clima di fiducia e sicurezza, grazie anche alla capacità di porre la domanda giusta al momento giusto (rispettando e, quando possibile, anticipando il timing del cliente, almeno per quanto riguarda lo psicologo). Il lavoro di entrambi è diretto verso la creazione di consapevolezza nel cliente, la progettazione di azioni efficaci (o più correttamente nel caso dello psicologo, alla loro stimolazione), alla determinazione di obiettivi (che, per lo psicologo, saranno necessariamente coerenti, adeguati e funzionali alle reali possibilità della persona che ha davanti) e alla gestione dei progressi del cliente (processo che, nel caso dello psicologo, si traduce nel consolidamento e nel rinforzo positivo degli stessi). Le undici competenze di base del coaching precedentemente menzionate, così come sono state stilate dall’ICF, sarebbero dunque a tutti gli effetti competenze psicologiche e poco importa se il coaching non è un intervento clinico, di fatto molti interventi psicologici non lo sono.
Se da un lato purtroppo esiste ancora il luogo comune secondo il quale chi va dallo psicologo è “fuori di testa”, dall’altro forse anche noi psicologi dovremmo riflettere sul fatto che proprio noi stessi abbiamo contribuito ad alimentarlo, focalizzandoci e cristallizzandoci da sempre un po’ troppo sulla clinica e sulla psicoterapia. Infatti, per quanto interessanti, stimolanti e complessi questi settori della nostra professione possano essere, non la rappresentano nella sua totalità e certo non ne esauriscono le innumerevoli potenzialità. Di fronte alla crescente popolarità di altre professioni per certi versi analoghe o che comunque invadono i nostri specifici ambiti di competenza, dovremo prendere coscienza del fatto che noi per primi abbiamo investito poco fino ad ora su un’immagine positiva dello psicologo. Forse è giunto il momento di invertire la rotta impegnandoci nel promuovere attivamente la figura dello psicologo come di “attivatore-promotore di risorse” e come professionista che utilizza, quando ciò è possibile, interventi brevi focalizzati sul qui ed ora. In altre parole, uno psicologo adatto a tutti.
Riferimenti bibliografici
(1) Da: http://www.icf-italia.org
(2) Intonti, P. (2000). L’arte dell’Individual Coaching. Franco Angeli, Milano.
(3) Piccardo, C. (1995). Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrato sulla persona.Cortina, Milano.
(4) Martellucci, P. M. (2005). Il counseling per il self empowerment. In: Di Fabio, A. & Sirigatti, S. (a cura di) Counselling prospettive e applicazioni. Ponte alle Grazie, Milano.
(5) Torre, E. (2005). La relazione d’aiuto: aspetti di complessità. In: Di Fabio, A. & Sirigatti, S. (a cura di) Counselling prospettive e applicazioni. Ponte alle Grazie, Milano.




_11.jpg)